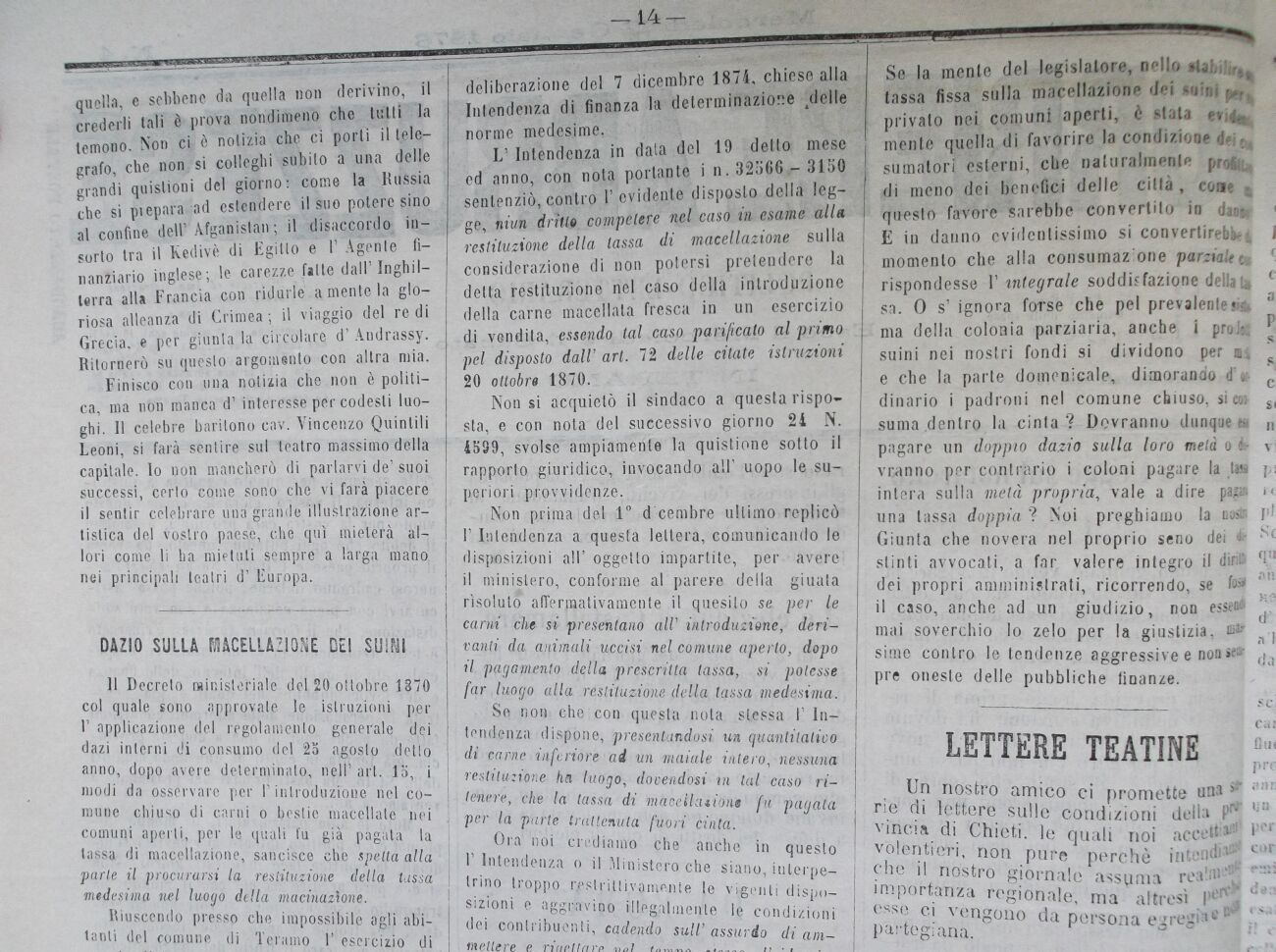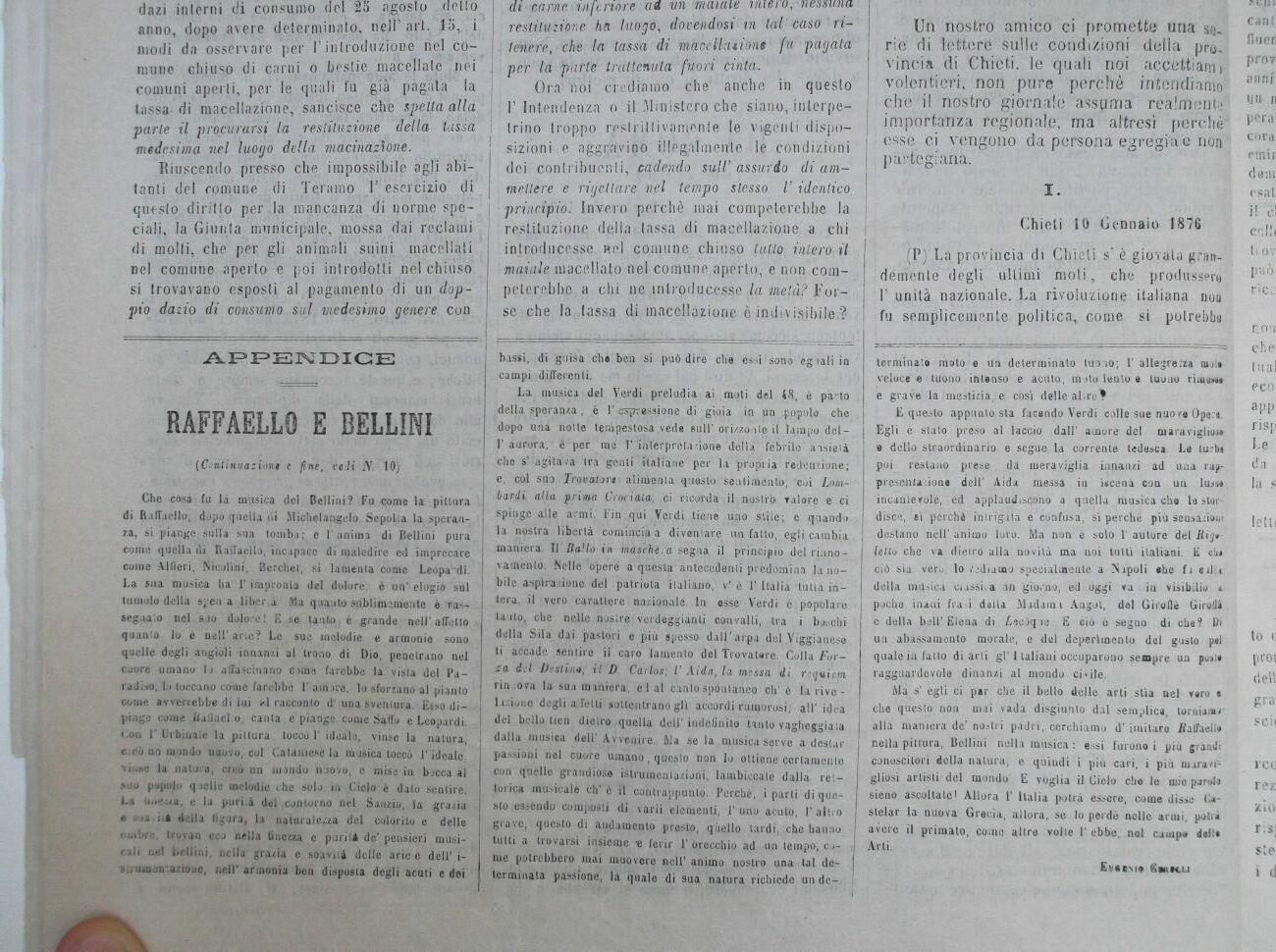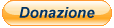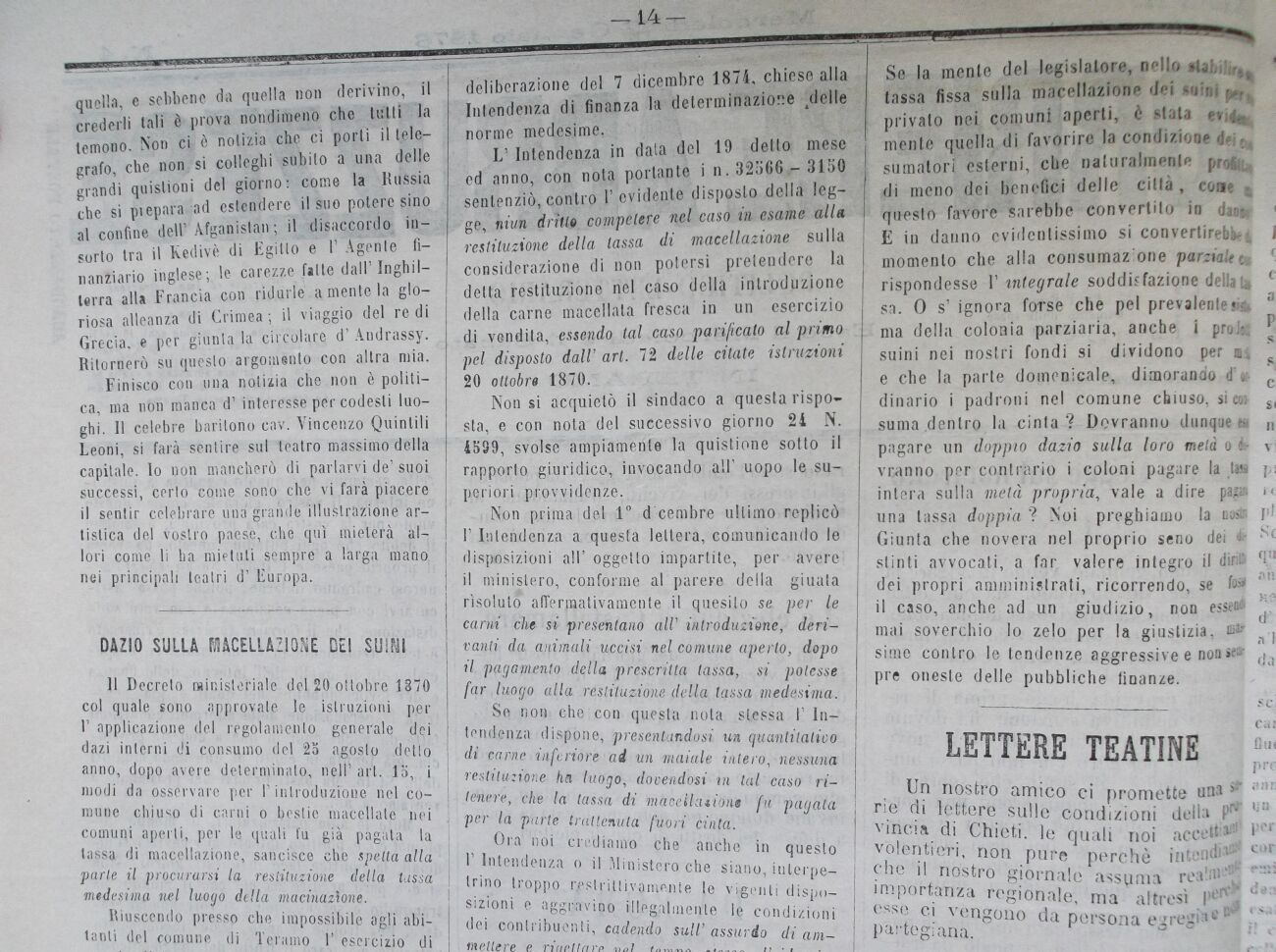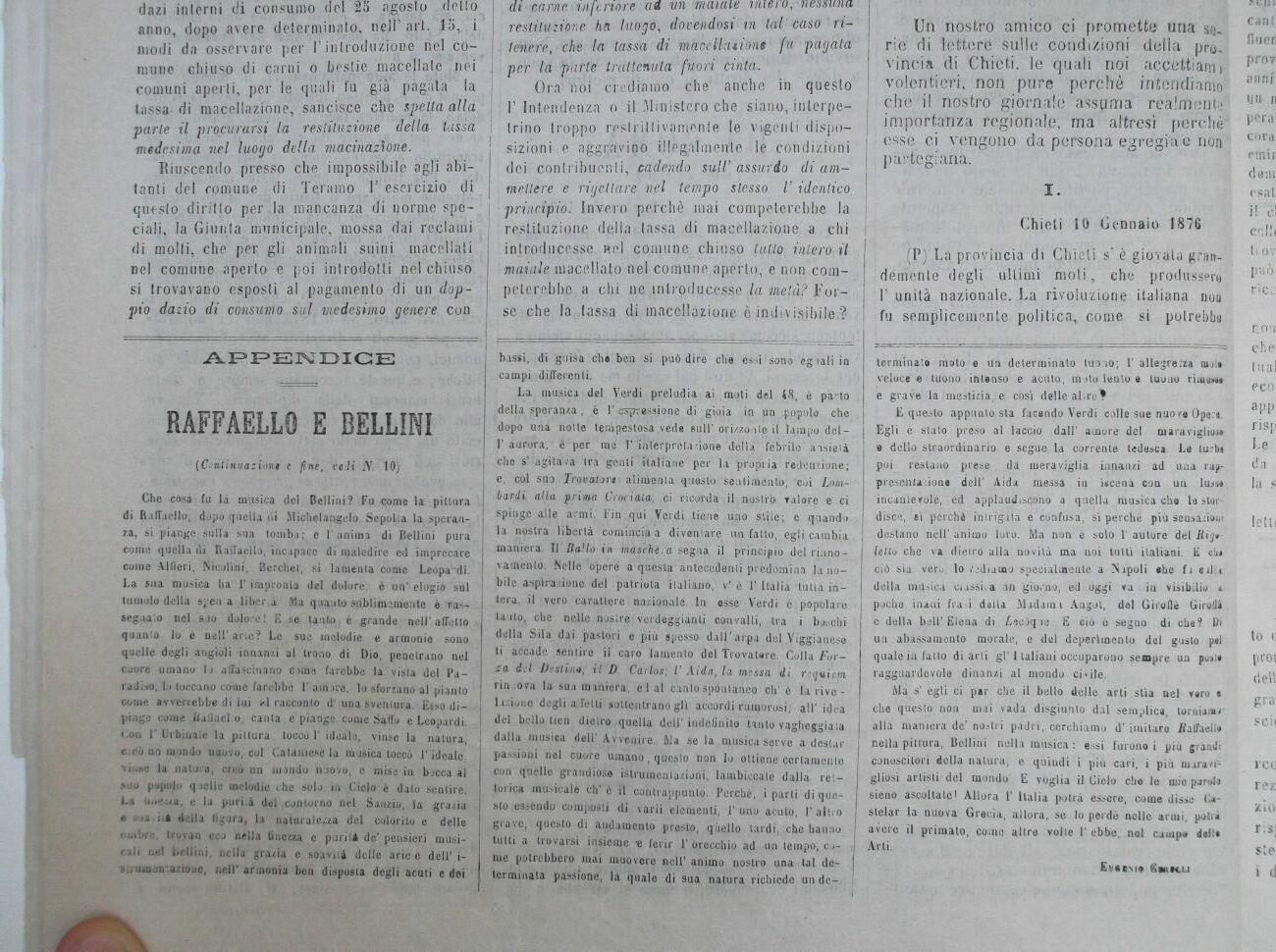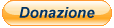Testo OCR meta' superiore della pagina
quella, e sebbene da quella non derivino, il crederli tali è prova nondimeno che tulli la temono. Non ci è notizia che ci porti ri telegrafo, che non si colleghi subito a una delle grandi quislioni del giorno: come la Russia che si pi epara ad estendere il suo potere sino al confine dell' Afganistan* il disaccordo insorto tra il Kedivè di Egitto e" 1' Agente finanziario inglese; le carezze fatte dall'Inghilterra alla Francia con ridurle a mente la gloriosa alleanza di Crimea; il viaggio del redi Grecia, e per giunta la circolare d1 Andrassy. Ritornerò su queslo argomento con altra mia.
Finisco con una notizia che non è politica, ma non manca d' interesse per codesti luoghi. II celebre baritono cav. Vincenzo Quintili Leoni, si farà sentire sul teatro massimo della capitale. Io non mancherò di parlarvi de' suoi successi, cerio come sono che vi farà piacere il sentir celebrare una grande lllustrtizionè artistica del vostro paese, che qui mieterà allori come li ha mietuti sempre1 a larga mano; nei principali teatri d' Europa.
DAZIO SULLA MACELLAZIONE DEI SUINI
11 Decreto nainisteriple del 20 ottobre 1870 col quale sono .approvale le istruzioni per T applicazione del regolamento generale dei dazi interni di consumo del 2b agosto eletto anno, dopo avere determinato, nel!' art. lt>, i modi da osservare per V introduzione nel comune chiuso di carni o bestie macellate jièi comuni aperti, per le quali fu già pagata' la tassa di macellazione, sancisce che spetta alla parte il procurarsi la restituzione della tassa medesima nel luogo della macinazione.
Riuscendo presso che impossibile agli abi-
19tiIì ìLnJ /*nmuna tU T
ni"i iy> fi
flgftl'rtiTl A
_cLL
deliberazione del 7 dicembre 1874, chiese alla Intendenza di finanza la determinazione 4delle norme medesime,
L'Intendenza in data del 19 detto mese ed anno, con nota portante i n. 32566 - 3150 sentenziò, contro l' evidente disposto della leg--ge, hiun dritta competere nel caso in esame alla restituzione della tassa di macellazione sulla considerazione di non potersi pretendere la delta restituzione nel caso della introduzione della carne macellata fresca in un esercizio di vendita, essendo tal caso, parificato al primo pel disposto dall' art. 72 delle citate istruzioni 20 ottobre 1870.
Non si acquietò il sindaco a questa risposta, e con nota del successivo giorno 24 N. 4599, svolse" ampiamente la quistione sotto il rapporto giuridico., invocando ali1 uopo le superiori provvidenze.
! Non prima del 1° dicembre ultimo replicò i Intendenza a. questa lettera, comunicando le disposizioni all' oggetto impartite, per avere il ministero, conforme al parere della giuata risoluto aflerjnativamente il quesito se per le carni che si presentano alV introduzione, derivanti da animali uccisi nel comune aperto, dopo il pagamento della prescritta tassa, si potesse far luogo alla restituzióne della tassa medesima.
Se nom che con questa nota slessa l'Intendenza dispone, presentandosi un quantitativo di carne inferiore ai un maiale iute re, nessuna restituzione ha luogo, dovendosi m tal' caso ' ritenere, che la tassa di macellatone fu pagata per la parte trattenuta fuori' tinta.
Ora noi crediamo che' anche in questo I Intendenza o il Ministero che siano, iuterpe-trino troppo r^striliivQmente le vigenti disposizioni e aggravino illegalmente le condizioni dei contribuenti, cadendo sull'assurdo di am-
Se la mente del legislatore, nello *taMlir*, tassa fissa sulla macellazione dei tuini privato nei comuni aperti, è stata e*t4e» mente quella di favorire la condizione dei % sumatori esterni, che naluralmenle profeta di meno dei benefici delle città, eoa? questo favore sarebbe convertito i o oaon E in danno evidentissimo si convertirebbe momento che alla consumazione parziale m rispondesse 1' integrale soddisfazione della t» sa. O s' ignora forse che pel prevalentesi& ma della colonia parziaria, anche i proiag suini nei nostri fondi si dividono per a; e che la parte domenicale, dimorando d a-dinario i padroni nel comune chiuso, si gesù ma dentro la cinta ? Dovranno dunque «a pagare un doppio dazio sulla loro metà o fc vcanno per contrario i coloni pagare la }m pi intera sulla metà propria, vale a dire pape una tassa doppia ? Noi preghiamo la caste pi Giunta che novera nel proprio seno dei è stinti avvocati, a far. valere integro il diritè fl,51 dei propri amministrati, ricorrendo, se ' ' il caso, anche ad un giudizio, non esseo& mai soverchio lo zelo per la giustizia, n j sime contro le tendenze aggressive e noase^ J pre oneste delle pubbliche finanze.
LETTERE TEATINE
Un nostro amico ci promette una * rie1 di lèttere sulle condizioni della p^ vincia di Chieti. le quali noi accetti^ volentieri, non pure perchè interni^ che il nostro giornale assuma reato1'-1® importanza regionale, ma altresì esse ci vengono da persona egregi partegiana.
Cai
Il in prc
IjU
per cor�
|
Testo OCR meta' inferiore della pagina
dazi inlcrni di consumo del zo agosio nello anno, dopo avere determinalo, nel!1 art. 15, i modi da osservare per l'introduzione nel comune chiuso di carni o bestie macellate nei comuni apei Ii, per le quali fu già pagata la tassa di macellazione, sancisce che spella alla parie il procurarsi la resliluzione della tassa medesima nel luogo della macinazione.
Riuscendo presso che impossibile agli abitanti del comune di Teramo 1' esercizio di questo diritio per la mancanza di norme speciali, la Giunla municipale, mossa dai reclami di molti, che per gli animali suini macellati nel comune aperto e poi introdotti nel chiuso si trovavano esposti al pagamento di un doppio dazio di consumo sul medesimo genere con
APPENDICE
RAFFAELLO E BELLINI
(Continuazione e fine, veli N. 10)
Che cosa fu la musica del Bellini? Fu come la pittura di Raffaello, dopo quella di Michelangelo. Sepolta la speranza, si piange sulla sua tomba; e l' anima di Bellini pura come quella di Raffaello, incapace di maledire ed imprecare come Alfieri, Nicoliui, Berchet, si lamenta come Leopardi. La sua musica ha F impronta del dolore, è un'elogio sul lumaio della s^en a libor.à. Ma quanto sublimemente è rassegnalo nel suo dolore! E se tanto è grande nell'afflitto quanto lo è nell' arie? Le sue melodie e armonie sono quelle degli angioli innanzi al irono di Dio, penetrano nel cuore umano lo affascinano carne farebbe la vista del Paradiso, li) toccano come farebbe 1' ainjre, lo sforzano al pianto come avverrebbe di lui A racconto d' una sventura. Esso dipinge come iiafiacPo, canta e piange come Saffo e Leopardi, pori {' Urbinate la pittura tocco , ideale, vinse la natura, e.cò un mando nuovo, col Calanìesc la musica toccò l'ideale. vhwt la natura, creù un mondo movo, e mise in bacca al suo popolo q ielle melodie che solo in Cielo è dato sentire, La tintutl, e la puruà del contorno nel Sanzio, la grafia e sja.iià della figura, la naturalezza del colorito e delle ouibre, irovan eco nella finezza c purità de'pensieri musi-cili uel bellini, nella grazia e soavità delle arie e dell'isti Hiiiiiu'.&7.10ne, nell' armonia ben disposta degli acuti e dei
di emme injcriore ai un maiale mieto, nessuna restituzione ha luogo, dovendosi in tal caso ritenere, che la tassa di macelkuione fu pagala per la parte trattenuta fuori Cinta.
Ora noi crediamo che1 anche in questo l1 Intendenza o il Ministero che siano, iuterpe-trino troppo reslritlivamente le vigenti disposizioni e aggravino illegalmente le condizioni dei contribuenti, cadendo sull' assurdo di ammettere e rigettare nel tempo slesso V identico principioì Inveio perchè mai competerebbe la resliluzione della lassa di macellazione a chi introducesse «el comune chiuso tulio intero il maiale macellato nel comune aperto, e non competerebbe a chi ne introducesse la metà? Forse che la tassa di macellazione è indivisibile ?
bassi, di guisa che ben si può dire che es^i sono egiali in campi differenti.
La musica del Verdi preludia ai moli del 48, è pa-to della speranza , è l'espressione di gioia in un popolo che dopo una notte tempestosa vede Bull' orizzonte il lampo dell'aurora, è per ma P'mlerprctauone della, febrilo ansieià che s' agitava Ira genti italiane per la propria redenzione; e, col suo Trovatore alimenta questo sentimento, coi Lombardi alla prima Crociala, ci ricorda il nostro Talore e ci spinge alle armi. Fin qui Verdi tiene uno siile; e quando la nostra libertà comincia a diventare un fatto, egli camhia maniera. II Ballo in maschera segna il principio del rinnovamento. Nelle opere a questa antecedenti predomina la nobile aspira/,ione del patriota italiano,' v' è P Italia tutia intera, il vero carattere nazionale. In osse Verdi è popolare la iio, che nelle nostre verdeggianti convalli, tra i ba.-chi dulia Sila dai pastori e più spesso dall'arpa del Viggianese ti accade sentire ii caro lamento del Trovatore. Colla Forza Bel Deslimil D. Carlos, l' Aida, la messa di requiem rin :ova la sua miniera, eJ al canto spontaneo cip è la rive-
l icione degli aifetti sollentrano gli accordi rumorosi, all' idea del bello tien dietro quella dell' indefinito tanto vagheggiata dalla musica doli'Avvenire, Ma se la musica serve a destar passioni nel cuore umano, questo non lo ottiene certamente con quelle grandiose islruinentazioni, lambiccale dalla re1.-torica musicale eh' ò il contrappunto. Perchè, i parti di questo essendo composti di varii elementi, 1' uno acuto, P altro grave, questo di andamento presto, quello tardi, che hanno tutti a trovarsi insieme *e ferir P orecchio ad un tempo, carne potrebbero mai muovore nell' animo nostro una tal determinala passione, la quale di sua natura richiede un dc-
Un nostro amico ci promette uria 111 rie di lettere sulle condizioni della prò, vincia di Chieti. le quali noi accettiamo volentieri, non pure perchè intendiamo che il nostro giornale assuma realmente importanza regionale, ma altresì perchè esse ci vengono da persona egregia © non partegiaria.
I.
Chieti 10 Gennaio 1876
cani
(P) La provincia di Chicli s" è giovata grandemente degli ultimi moti 1 che produssero 1' unità nazionale. La rivoluzione italiana nou fu semplicemente politica, come si potrebbe
terminalo moto e un determinato tuo io; 1' allegre:za mÉ veloce e tuono intenso e acuto, malo lento e tuono rimase e grave la mestizia, e così delle altre*
E questo appunto sta facendo Verdi colle sue nuore Opere. Egli è slato preso al laccio dall' amore del maraviglio!» , dello straordinario e segue la corrente tedesca. Le turba poi restano prese da meraviglia innanzi ad ima rappresentazione dell' Aida messa in ìtteena con uu lusa» incantevole, ed applaudiscono a quella musica che la stordisca, sì perchè intrigata e confusa, sì perchè più sensazioni destano nell' animo loro. Ma non è solo 1' autore del Ri'jv-letto che va dietro alla novità ma noi tutti italiani. E eh* ciò sia veru lo Adiamo specialmente a Napoli ehe fi eilU della musica ciasska an giorno, ed oggi va in visibilio a pocho inani fra-i dalla Madami Angui, del Giroflè Giro!]» e della ball'Elena di Zscàq io. E ciò ò segno di che? Di un abassameulo morale, e del deperimento del gusto pel quale in fallo di arti gl' 1 laliani occuparono sempre un posi» ragguardevole dinanzi al mondo ci» ile.
Ma s' egli ci par che il bello delle arti stia nel vero e che questo non mai vada disgiunto dal semplice, torniamo alla maniera de' nostri padri, cerchiamo d' imitare Raffaella nella pittura, Bellini nella musica: essi furono i più grandi conoscitori della natura, e quindi i più cari, i più ni ara tigliosi artisti del mondo E voglia il Cielo cho le mie parola sieno ascoltate' Allora l' Italia potrà essere, coiste dissi* Ga-slelar la nuova Grecia, allora, se lo perde nelle armi, polii avere il primato, come altre volle P ebbe, noi camp» dell* Arti.
EtfsrM» Kwhi.I�
|